ETICA GRECA ED ETICA BUDDHISTA, conferenza del prof. Giangiorgio Pasqualotto.
“Etica Greca ed Etica Buddhista”
conferenza del professor Giangiorgio Pasqualotto, Verona, aprile 1994 (registrazione e trascrizione di Pier Prospero)
Per il buddhismo chi riesce a superare il vincolo del tempo supera il “karma” e quindi si pone al di fuori del ciclo delle reincarnazioni, del ciclo della storia; quindi liberarsi dalla struttura “passato-presente-futuro” significa liberarsi dal “karma”.
Vediamo come è stato affrontato questo punto fondamentale nell’Etica Greca.
Iniziamo da Epicuro.
Dal punto di vista concettuale il punto fondamentale dell’etica epicurea è il passo in cui si dice: “il tempo finito e il tempo infinito apportano lo stesso piacere, se non si misura con la ragione”.
Cioè si afferma che non c’è nessuna differenza tra il tempo finito e quello infinito: apportano lo stesso piacere.
La conseguenza di questa formulazione logica si trova in un passo di una famosa epistola in cui Epicuro prende posizione contro la “speranza” e quindi contro quella che sarà una delle virtù cristiane per eccellenza.
Epicuro dice: “io invece invito ad assidui piaceri e non a virtù che comportino stolte, vuote e perturbatrici speranze di ricompensa”.
Questo brano è stato sempre letto in maniera “volgare” dai detrattori di Epicuro che volevano dimostrare che egli, e tutti i greci, cercavano solo i piaceri e non speravano in un mondo migliore.
Un’interpretazione completamente sbagliata perché interessata, perché apologetica di tutt’altro tipo di dottrina.
Infatti il piacere per Epicuro si distingue in piacere cinetico e piacere catastematico:
Il piacere cinetico è il piacere dovuto al desiderio di avere qualcosa ed è praticamente senza fine; questo piacere cinetico è, per così dire, il piacere “volgare”.
Naturalmente la tradizione antiepicurea ha sempre tentato di schiacciare Epicuro su questo piacere cinetico che invece, come lo stesso Epicuro ha sempre affermato, non è il vero piacere poiché per Epicuro il vero piacere è quello catastematico, cioè il piacere della “galene” (che in greco significa “bonaccia del mare”), della tranquillità che si ha laddove non vi sono onde perturbatrici.
Allora si può capire che, come dice Epicuro, se si inizia a sperare nel futuro o si è tormentati dai rimorsi del passato il piacere catastematico non ci può essere perché la mente è perturbata e quindi ci si agita; ci si agita perché si diventa ansiosi o perché si è melanconici o nostalgici.
I manuali scolastici non fanno onore alla verità quando diversificano lo stoico Seneca dagli epicurei mentre in moltissimi casi, come in questo sulla questione del tempo, lo stoico Seneca è radicalmente epicureo.
Questo discorso di Epicuro, di eccezionale chiarezza, viene ripreso nell’Epistola 101 di Seneca a Lucilio nella quale lo stoico Seneca dice: “non rinviamo niente al futuro, chi ogni giorno ha saputo dare l’ultima mano alla sua vita non ha bisogno del tempo; ora da questo bisogno nasce, con la paura del domani, anche quella cupidigia del domani che rode l’anima. Quale mezzo abbiamo per sfuggire a questa inquietudine? Uno solo: non permettere che la vita si protenda verso l’avvenire, ma ricondurla al presente. L’uomo che si è preparato in modo da vivere ogni giorno la vita nella sua pienezza è veramente sicuro di sé (cioè non ha più paura), ma chi fa della speranza una ragione di vita (ecco Epicuro che ritorna nelle parole di Seneca) si vede sfuggire il presente di ora in ora e subentra in lui, con il desiderio di sopravvivere (cioè con il desiderio dell’immortalità), la paura della morte, sentimento spregevole ogni momento della vita.”
Infatti chi desidera l’immortalità la desidera perché ha un folle terrore della morte, cosa che per lo stoico Seneca è un sentimento spregevole.
Qui sono concentrati tutti gli elementi fondamentali per cui quella Epicurea è un’etica autenticamente garante della tranquillità dell’animo, la “tranquillitas animi” dei latini, e quindi della “galene” per i greci e del “nirvana” in termini buddhisti.
Questa garanzia si può ottenere solo se si elimina la terrificante scansione: passato-presente-futuro.
Affrontiamo anche la questione del passato: se la speranza di un futuro migliore o il terrore di un futuro peggiore sono causa di perturbamento, non meno perturbante è il rivolgimento al passato, a ciò che abbiamo fatto o non abbiamo fatto.
Basta pensare alla radice della melanconia: malattia che già Ippocrate aveva ben focalizzato dicendola dovuta a “fobos” cioè alla paura e a una cosa che si potrebbe tradurre “depressione”, che attribuiva a chi guarda al passato rimpiangendolo perché non c’è più; la peggiore delle sue conseguenze, per Epicuro, è quella che vede tutto, presente e futuro, come se fosse già passato per cui nulla vale più la pena (vanitas vanitatum) di fare o pensare perché è tutto bloccato, cristallizzato nel passato e quindi porta l’immobilità totale, tant’è vero che Ippocrate dice: “la conseguenza più terrificante della melanconia è la paralisi” intendendo proprio in senso fisico la paresi.
Questo gioco del tempo produce dei disagi sia nel verso del passato, sia nel verso del futuro.
Nei testi Zen troviamo la stessa valorizzazione del presente.
La pratica più importante per lo Zen è la meditazione e parlando della meditazione occorre ricordare che il nucleo focale della meditazione buddhista è la presenza mentale: presenza mentale per i buddhisti vuol dire allenare la mente ad essere perfettamente presente a quello che succede in ogni momento, senza distrazione, cioè senza quello che in Birmania si definisce “la scimmia della mente” che salta da un pensiero all’altro, da una preoccupazione all’altra, da un ricordo all’altro, e che evidentemente impedisce di essere presenti.
Anche questo allenamento alla presenza mentale, che nella pratica della meditazione è uno degli ostacoli più grandi, consiste nel riuscire ad essere presenti, o si dice anche ad essere attenti.
Uno dei più grandi maestri Zen della tradizione, il cinese Lin Chi (in Giappone chiamato Rin Zai) fondatore della scuola “Rin Zai”, cioè di quella scuola Zen che utilizza i “koan” e i “mondò” (l’altra scuola è la “Soto” che non vi ricorre) in un famoso passo della raccolta dei suoi discorsi esprime questo concetto: “quando mi viene fame mangio il mio riso, quando mi viene sonno chiudo gli occhi, …, gli sciocchi ridono di me, ma il saggio comprende.”
Questo pensiero, che poi è stato enormemente equivocato, per una interpretazione data dal senso comune ad un primo livello, è considerato una banalità.
Ad un secondo livello di interpretazione, quello moralistico di chi pretende di avere la verità, viene considerato una riprova che i buddhisti sono degli epicurei e degli individualisti perché fanno quello che vogliono nel momento che hanno bisogno di farlo, e quindi affermano la negazione totale di ciò che per i moralisti è l’etica, cioè non fare quello che piace, ma solo aiutare gli altri.
In realtà il concetto di Lin Chi significa solamente che egli è perfettamente attento al momento presente.
Se trasponiamo questo concetto sul piano dell’etica buddhista, per esempio nella questione della compassione, il problema consiste nel non farsi un problema della compassione: avere un atteggiamento aperto, attento a ciò che succede davanti, a ciò che avviene; non preoccuparsi per ciò che potrebbe avvenire perché questo non coglie il bersaglio e non riesce ad essere efficace; intervenire nel momento in cui bisogna intervenire, ma non farsi un problema dell’intervento, il che vorrebbe dire, in senso etimologico stretto, essere “pre-occupati” di intervenire.
La maggior parte della nostra etica occidentale è costruita proprio sulla “pre-occupazione” di intervenire.
Poi, nel momento in cui si deve intervenire, non si riesce a farlo perché si è talmente affaticati dalla “pre-occupazione” di intervenire che non ci sono più energie disponibili. Questo vale, ovviamente, per il senso comune, non per i Santi.
L’importanza della frase di Lin Chi sta quindi in questa accentuazione del presente.
Quello che dice un maestro contemporaneo può aiutare a spiegare meglio questi concetti: “conviene essere completamente presenti in ogni gesto, concentrarsi qui e ora, in questo può essere riassunta tutta la lezione dello Zen.”
Per dimostrare che non sono concetti propri solo allo Zen ma di tutti i grandi maestri buddhisti, vediamo che un maestro birmano del buddhismo Teravada dice: “La retta presenza mentale libera l’uomo dalle catene del passato che egli scioccamente cerca di rinsaldare volgendosi indietro troppo frequentemente verso di esso con occhi pieni di bramosia, risentimento o rimpianto. La retta presenza mentale impedisce all’uomo di incatenarsi anche ora mediante le fantasie delle sue paure e delle sue speranze: incatenarsi a eventi anticipati del futuro. Così la retta presenza mentale restituisce all’uomo una libertà che si deve trovare solo nel presente. Quindi prendere coscienza della verità significa vivere ed esistere qui e ora.”
E ancora, un grande divulgatore del buddhismo in occidente, l’inglese Humphreis, dice: “Soltanto quando sappiamo vedere giusto, cioè vedere le cose e le situazioni come sono, possiamo agire direttamente nei loro confronti. Vedere così chiaramente significa far cadere ciò che sta tra noi e la vista: come possiamo vedere un albero quando intervengono pensieri su di esso, o un cane quando abbiamo paura che ci morda, o un’idea quando siamo curiosi di sapere quale impatto avrà su di noi nell’azione? Soltanto spogliandoci di piani e di scopi, di paure e di amori possiamo vedere ciò che ci sta di fronte sia questo un essere umano, una richiesta di tasse o qualcosa di buono da mangiare.”
Notiamo come la “presenza mentale” sia fondamentalmente radicata nella percezione e soprattutto nell’esperienza dell’impermanenza.
Se riusciamo non solo a capire, ma anche a sperimentare che tutto è impermanente, allora perché dovremmo aver paura del passato o del futuro, se questa logica dell’impermanenza travolge sia il passato che il futuro?
… 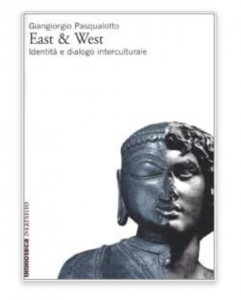
(Capire) che tutto è impermanente, passato e futuro, e tuttavia agire, compiere un’azione, ma se compiamo un’azione che per motivo fondamentale ha un obiettivo da raggiungere corriamo il pericolo di rimanere attaccati a questo obiettivo, di rimanere subalterni: cioè di compiere l’azione solo per raggiungere l’obiettivo.
Se si è, invece, abbastanza addentro alla pratica dell’esperienza dell’impermanenza si riesce a capire che anche la nostra azione è impermanente e quindi non la si caricherà di tutto quel significato e di tutta quell’importanza che le si darebbe invece se si resta attaccati alla temporalità dell’azione.
Quindi il discorso dell’impermanenza, sul quale è sempre bene insistere, si applica a tutto, anche alla struttura dell’azione, non facendoci più attaccare all’azione.
Al livello della pratica della santità, ma solo a questo livello, questi concetti sono presenti anche nella tradizione cristiana e sostanzialmente si ritrovano nel metere in guardia contro il peccato di orgoglio: ciò che nel buddhismo noi troviamo come consiglio di non attaccamento, nel cristianesimo è il consiglio di non inorgoglirsi.
Non inorgoglirsi è fondato proprio sul fatto che l’azione, per quanto importante sia, è in realtà marchiata dalla “vanitas” cioè dalla transitorietà. Non è quindi così importante: in entrambe le tradizioni si dice che anche se si salvano mille persone, o il mondo intero, non si deve credere di aver fatto più di quello che si poteva fare. Nel cristianesimo veramente prevale “quello che si doveva fare” e non è una differenza trascurabile, anche se ai livelli più alti della mistica cristiana il concetto coincide con quello buddhista.
Il Buddhismo è straordinario (e per alcuni è terrificante proprio per lo stesso motivo per cui è straordinario) poiché, esattamente come fa Socrate, non sostituisce la sua verità alle verità distrutte.
Sarebbe troppo comodo al posto del Dio giudaico-cristiano, di Allah, della Storia, ecc. mettere Buddha e sentirsi a posto, sport che del resto è ampliamente praticato. Questa operazione a noi non interessa poiché la Storia occidentale ha prodotto e immagazzinato moltissimi valori migliori di quel Buddha.
Lo straordinario messaggio del buddhismo è l’affermazione che se ci si attacca a un valore, di qualsiasi colore esso sia, si è salvati solo in apparenza, mentre in realtà si è fregati proprio perché per salvarsi si dovrà sempre aggrapparsi, richiamarsi, a questo valore come a una specie di “maniglia” esterna e non si sarà mai autonomi, non si riuscirà a essere liberi, trasparenti, non si riuscirà a vivere il presente, si dovrà sempre avere questo riferimento esterno.
Qualcuno potrà sentirsi anche pacificato in questo modo, ma i più ne rimarranno vittime poiché la “maniglia” fuori di noi è estremamente lacerante in quanto continua a sottolineare il fatto che la verità è fuori di noi in qualche altro posto che dobbiamo sempre sforzarci di raggiungere.
In relazione a questo potrebbe sorgere un dubbio rispetto al ruolo dei “Lama” tibetani: il Dalai Lama è stato infatti anche un capo politico per ragioni storiche, infatti in un periodo in cui c’era necessità di unità interna al Paese per bloccare le invasioni l’unica autorità disponibile era quella religiosa che venne perciò trasformata in autorità politica.
Ma il Dalai Lama non è affatto l’equivalente del Papa cattolico perché non è “il capo di tutti i buddhisti” ma solo l’esponente più autorevole di una delle tradizioni buddhiste, per cui certamente un buddhista giapponese rispetterà la sua autorevolezza, ma non si sentirà assolutamente vincolato da questa.
In concreto, il Dalai Lama non può ordinare o impedire la costruzione di un monastero in Birmania o a Ceylon, non può “scomunicare”, e se interviene sulla dottrina sono opinioni sue o della sua scuola che non vincolano nessuno alla fedeltà a quanto affermato.
Sebbene il Dalai Lama abbia avuto un’autorità come capo politico, per i buddhisti ha un’autorità spirituale, non dottrinale.
Questa è la realtà, nel bene e nel male, poiché il Buddhismo non ha un’organizzazione “ecclesiastica” come le altre religioni e quindi dispone di una forza molto minore.
Alcuni però individuano proprio in questa mancanza di forza la sua “fortuna” poiché, non avendo una rigidità dogmatica, è penetrato dolcemente, come l’acqua piuttosto che come il fuoco, e si è adattato all’esistente.
Tanto è vero che tra il Buddhismo tibetano e quello giapponese apparentemente vi è ben poco in comune e questo perché il pensiero buddhista si è adattato e sovrapposto alle tradizioni culturali precedenti: in Tibet alla tradizione sciamanica e in Giappone allo “Scinto”.
Infatti nel Buddhismo Tibetano sono presenti molti riti sconfinanti nella magia, derivati dalla precedente cultura che il Buddhismo non ha mai perseguitato con l’intento di eliminarli.
Il grande vantaggio del buddhismo è quindi di non essere mai stato dogmatico non avendo una dottrina fissa, ma questo è anche il suo svantaggio perché nella sua storia non si trova un missionarismo fondato sull’ “indottrinamento” con principi fissi, analogo a quello cristiano, anzi nella tradizione l’atteggiamento del buddhista che spiega il suo pensiero è quello di un saggio che attende che gli sia chiesto qualcosa, piuttosto di quello di chi va a tirare per la giacca l’infedele.
Consigliando di non aggrapparsi ad un riferimento esterno credendo di “salvarsi”, entrambe le tradizioni etiche, Greca e Buddhista, invece di indicare una verità esterna che si deve sforzarsi di raggiungere dicono: “intanto tacere e ascoltare cosa c’è all’interno”.
Andando a vedere bene, anche nella tradizione cristiana si possono trovare dei passi eccezionali nei quali si sottolinea come la “conversio” non sia un’esperienza solamente metafisica, ma innanzitutto sia una “conversio oculorum” – un rivolgimento degli occhi – che viene normalmente travisato interpretandolo come un “rivolgere gli occhi a Dio” mentre sta per “rivolgere gli occhi al proprio interno” poiché il significato di “conversio” è qualcosa come un’inversione a “U”, quindi se gli occhi sono sempre volti all’esterno occorre per prima cosa rivolgerli all’interno e vedere cosa abbiamo dentro.
Il Buddhismo dice anche che occorre prepararsi, essere pronti, per questa “conversio” e che ci deve essere sempre qualcuno che ci assiste, materialmente più che spiritualmente, quando si va a vedere cosa abbiamo dentro, perché può essere difficile accettare quello che si vede.
Questo argomento ci porta al problema dei “Testi Sacri”: il testo sacro è stato scritto addirittura da Dio, che è lontano da noi e quindi occorre riavvicinarsi a questa fonte, perciò nelle tradizioni giudaico-cristiana e islamica la lettura dei testi sacri è assolutamente necessaria poiché, per queste tradizioni, leggendoli ci si riavvicina a Dio.
Anche se alcuni buddhisti, essendo stati trattati per troppo tempo come dei miscredenti e degli atei, hanno voluto farsi accreditare come portatori di una religione universale e quindi come possessori di testi sacri, questa si può forse considerare come una “legittima difesa”, poiché i buddhisti sono stati bersagliati da tutte le parti, ma rimane una inequivocabile distorsione, dato che è sempre stato chiaro che il Buddhismo non ha testi sacri: i Sutra infatti sono considerati delle riflessioni profonde ma non “parola rivelata” da qualche divinità.
Invece nella tradizione giudaico-cristiana e in quella islamica sappiamo che le parole che leggiamo sui Testi sono considerate parole scritte sì da uomini, ma sotto dettatura diretta di Dio e questo è un fatto per niente trascurabile poiché le rende parole che non possono essere messe in discussione, ma solo interpretate – aprendo tutta la questione di chi sia autorizzato a interpretarle e del suo potere – senza discutere la loro verità intrinseca.
I Sutra sono delle riflessioni di intelligentissimi Maestri di altissimo livello, degnissimi, ma uomini: non sono quindi parola di Dio, tanto è vero che l’espressione “Scritture Buddhiste” non equivale a “Scritture Cristiane”, perché per “Scritture Buddhiste” si devono intendere tutte quelle che si sono accumulate lungo i secoli senza che una escluda l’altra anche se portano interpretazioni completamente diverse come, ad esempio, l’interpretazione idealista e quella materialista.
In questa tradizione nessuno si è mai sognato di affermare che uno è Buddhismo e l’altro no, sono stati semplicemente sovrapposti diversi punti di vista sulla stessa realtà e quindi abbiamo una sterminata quantità di testi buddhisti che vanno tutti tenuti nella medesima considerazione e varie Scuole che esprimono punti di vista anche molto diversi, ma considerati equivalenti e da studiare tutti.
Il Buddhismo quindi non ha testi sacri esattamente come la tradizione Greca: portano semplicemente delle testimonianze di uomini che hanno compiuto un itinerario, un’esperienza, degni di essere tramandati.
I Testi di queste due tradizioni non sono testi rivelati, non c’è nessun Dio che ha dettato queste parole, sono testi che contengono la registrazione dei discorsi del Maestro: come per i testi di Socrate o Pitagora, il Canone Buddhista è semplicemente il resoconto di ciò che gli allievi – o allievi di allievi – del Buddha hanno sentito che lui diceva in varie occasioni, e quindi non vi è nulla di sacro.
Il centro è l’insegnamento del Maestro per cui sono stati tramandati tutti quei rituali di uomini e donne che si recano al Monastero con le loro richieste, i loro dubbi, e Maestri, che non sono poi così accessibili, infatti fanno attendere giorni, mesi, anni, prima di incontrare chi vuole arrivare a seguire questi insegnamenti che deve così dimostrare una volontà e una capacità non comuni.
Oppure in Grecia si può citare l’esempio molto significativo descritto ne “La vita di Pitagora” di Giambico, che è tuttora piacevole e interessante da leggere, dove si racconta come Pitagora facesse attendere tre anni per ottenere di entrare nella sua scuola e poi facesse osservare altri cinque anni di silenzio a chi vi era entrato per essere ammesso ad ascoltare il Maestro dal di fuori di una tenda, senza quindi poterlo vedere; solo a chi aveva affrontato diverse altre prove era concesso di entrare nella tenda al cospetto del Maestro.
Questo per significare come in queste due tradizioni antiche il bisogno spirituale fosse tenuto in estrema considerazione e misurato in tempi lunghissimi: non vi erano i detentori della verità e gli ascoltatori della verità per cui i primi insegnano ai secondi alcuni contenuti. Per il Buddhismo infatti l’unica cosa da insegnare è come eliminare tutti i contenuti per vedere cosa succede dopo.
La meditazione è quindi l’igiene mentale per eliminare questi contenuti e rendere tutto pulito in modo che le cose risaltino nella loro verità.
Per questo possono coesistere il Buddhismo Zen e quello Tibetano che portano le maggiori accentuazioni in direzioni diverse.
Tornando al parallelo tra etica Greca antica ed etica Buddhista, vediamo qual è il loro denominatore comune, oltre alla questione del tempo.
In entrambi i casi è necessario che il soggetto, l’individuo, sia purificato e abbia raggiunto la verità o l’illuminazione, a seconda della tradizione, per poter autenticamente aiutare gli altri, e questo costituisce la grande differenza tra queste due etiche e quella cristiana.
Detto in altri termini, occorre arrivare – ciascuno secondo le sue possibilità – al livello di “bodhisattva” costruendo la propria purificazione interiore per poter poi “tornare nel mercato” come dicono i buddhisti.
Infatti se si inizia ad aiutare gli altri – che è l’ossessione religiosa occidentale, luterana in particolare – quando ci si trova in una di quelle fasi precedenti in cui si è ancora turbati, in cui si è ancora in cerca della propria verità, molto probabilmente si possono produrre dei disastri agli altri e anche a se stessi.
Se ci si proietta all’esterno quando non si è ben saldi all’interno, quando non si è ancora trovato il proprio baricentro, il proprio “deimon” come dicevano i Greci, la propria “verità”, si compie un’operazione che molto spesso si rivela dannosa, nel lungo periodo, se non immediatamente.
Ci si attacca all’azione, all’esteriorità, semplicemente ci si inorgoglisce per le “opere esteriori”, come avrebbe detto Lutero, cioè per il fare verso gli altri, senza vedere se questo fare è motivato, è radicato, ha una buona base, una sua solidità, poiché si è soddisfatti solo di vedere qualcosa che viene realizzato.
L’Etica buddhista è invece tutta preventiva: lavora sulle condizioni dell’azione, non sui risultati dell’azione; sulle cause profonde dell’azione, non sugli effetti.
Gli effetti possono essere anche spettacolari, pur rimanendo non duraturi o dannosi e deleteri; infatti la spettacolarità non è un criterio etico: cioè l’apparente grande efficacia immediata di un’azione non è un criterio etico per valutarla, e questo è un assunto fondamentale comune all’etica buddhista e a quella greca.
Nell’etica della cultura greca, non solo in Epicuro, ma anche in Aristotele e nei tragici, l’elemento fondamentale è quello dell’ “autarke” cioè dell’ autonomia: l’individuo deve essere abbastanza forte da essere autonomo e per “autonomo” l’etica greca voleva significare non tanto autonomo da ciò che circonda materialmente l’individuo, ma autonomo da verità precostituite, da sistemi dottrinari, mitologici, religiosi, politici, statali e quindi autonomo in senso etico, non materiale. Era chiaro che l’individuo non può essere autonomo in assoluto poiché deve respirare, mangiare e bere, usare cose fatte da altri, ecc. e questo i Greci lo sapevano molto bene quando dileggiavano quelli tra loro che interpretavano l’ “autarkeia” in senso puramente materiale e si facevano tutto, dalle scarpe alle imbarcazioni, pensando in questo modo di essere “autonomi” mentre la vera “autarkeia” è l’indipendenza dai lacci teorici, etici, ideologici che stringono l’individuo, è, come afferma il Buddhismo, essere indipendenti anche dal Maestro.
In un testo, Buddha indica di rifiutare ciò che viene dal sentito dire, dall’autorità dei maestri o dei testi, esprimendo il medesimo concetto di autonomia e di libertà. Libertà per il buddhismo non significa fare ciò che si vuole, ma essere liberati-purificati da ciò che ci costringe.
La grande differenza tra etica Greca e etica Buddhista è data, molto in sintesi, dal fatto che l’etica Greca va ancora riferita all’individuo, mentre l’etica Buddhista tende ad andare al di là dell’individuo poiché vuol rendere liberi anche dalla propria individualità. La differenza tra le due etiche sta quindi nel riferimento.
L’etica Greca ha sempre come punto di riferimento il soggetto umano (l’individuo non la “persona” poiché questa è una categoria che nascerà soltanto con il cristianesimo) infatti quando parlano Socrate, Epicuro, Seneca, si riferiscono sempre all’individuo e quindi nell’etica Greca è dall’individuo che parte l’azione buona.
Nel buddhismo si trova una posizione che potremmo definire più avanzata, che si porta più in profondità e proprio per questo è molto più difficile; consiste nella teoria/esperienza dell’ “anatta” (assenza di un sé assoluto) e cioè nel considerare che l’azione migliore non è quella che si compie partendo dalla supposizione che ci sia un soggetto responsabile nel bene e nel male, agente di questa azione, ma quella che scaturisce – al contrario – nel momento in cui questa illusoria credenza e fiducia nell’io scompare, cioè quando non si ha più la percezione di essere stati protagonisti dell’azione. Quindi per il buddhismo l’azione migliore avviene quando sono state tagliate radicalmente alla base le ragioni dell’attaccamento all’azione e ai frutti dell’azione stessa.
In questo sta la vera differenza tra l’etica Buddhista e quella Greca, una differenza che collega il Buddhismo all’etica Induista precedente e, stranamente, ai livelli più elevati della mistica cristiana, non però alla dogmatica cristiana e poi cattolica.
Alla mistica cristiana laddove, come in Ekkart, si dice che “l’azione più nobile è quella fatta con il massimo del distacco”, e il massimo del distacco si ha non tanto, o solamente, con il semplice distacco materiale dai beni, ma con il distacco dall’idea stessa di “io”, il distacco dall’azione e dai meriti dell’azione.
Questo passaggio ulteriore, questo punto più avanzato dell’etica Buddhista è per noi occidentali veramente inquietante e difficilissimo da attuare.
Il Buddhismo vede la realtà come una rete infinita, chiamata “Rete di Indra”* che, nell’intersecarsi delle sue linee negli infiniti piani, forma dei prismi detti “gioielli”, per cui per significare la completa interrelazione delle parti si dice che “lo splendore di ciascun gioiello della rete di Indra dipende dallo splendore di tutti gli altri gioielli” e la conclusione logica è “uno in tutto, tutto in uno, tutto in tutto, uno in uno”.
Le linee sono comuni a tutti i prismi come maglie di una rete tridimensionale, dove ciascun nodo è costituito dagli stessi fili che costituiscono anche tutti gli altri nodi, per cui se si tira o allenta uno dei nodi si avranno ripercussioni e modificazioni su tutta la rete.
Questo è un concetto di eccezionale importanza nel buddhismo poiché significa che ciascun elemento della rete è “anatta” (dal sanscrito “an-atman”) “privo di sé assoluto” e cioè che ciascun elemento fisico, come ciascun individuo, non è assoluto, ma relativo, e cioè esiste ed è costituito per le sue relazioni.**
Cerchiamo di semplificare con l’esempio della catena genetica: ciascuno di noi non è un’entità autonoma e assolutamente individuale poiché siamo sì individui, ma costituiti geneticamente e inseriti in una catena, cioè siamo figli di qualcuno e genitori di qualcun altro e per questo, ad esempio, in Cina tradizionalmente per definire una persona si ricorre al fatto, prima che è il figlio del tale e il genitore del tal altro, poi che appartiene a quella famiglia la quale appartiene a quel gruppo che a sua volta è parte di quella tribù, non partendo mai dal nome del singolo direttamente.
Questo non provoca una disintegrazione dell’individualità e quindi una irresponsabilità, anzi provoca il massimo della responsabilità.
Per tornare all’etica, in questo modo si ottiene il massimo di responsabilità perché si è consapevoli che ogni nostra azione, ogni movimento, si ripercuote su tutto l’universo, che ogni nostro gesto ha una ripercussione sia nello spazio che nel tempo e quindi ogni azione sarà fatta con estrema attenzione.
__________________________________________________________________
*: Vedi il testo di Garma Chang “La dottrina buddhista della totalità”, ed. Ubaldini.
**: Vedi i testi di F. Capra e specialmente “Il Tao della Fisica”, oltre ad altri testi di cibernetica e di ecologia che spiegano in termini moderni il concetto di sistema e quello di feed-back.




